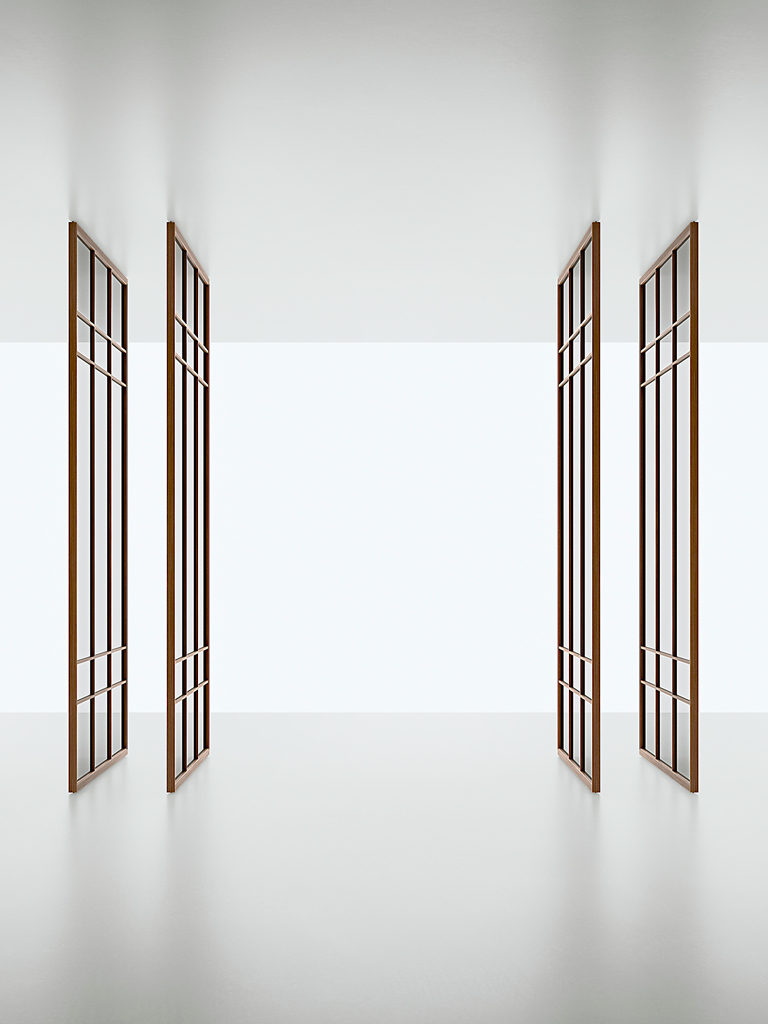Back to Modernity
La modernità secondo Stefano Salis, Maria Cristina Didero, Giuseppe Lupo e Deyan Sudjic.
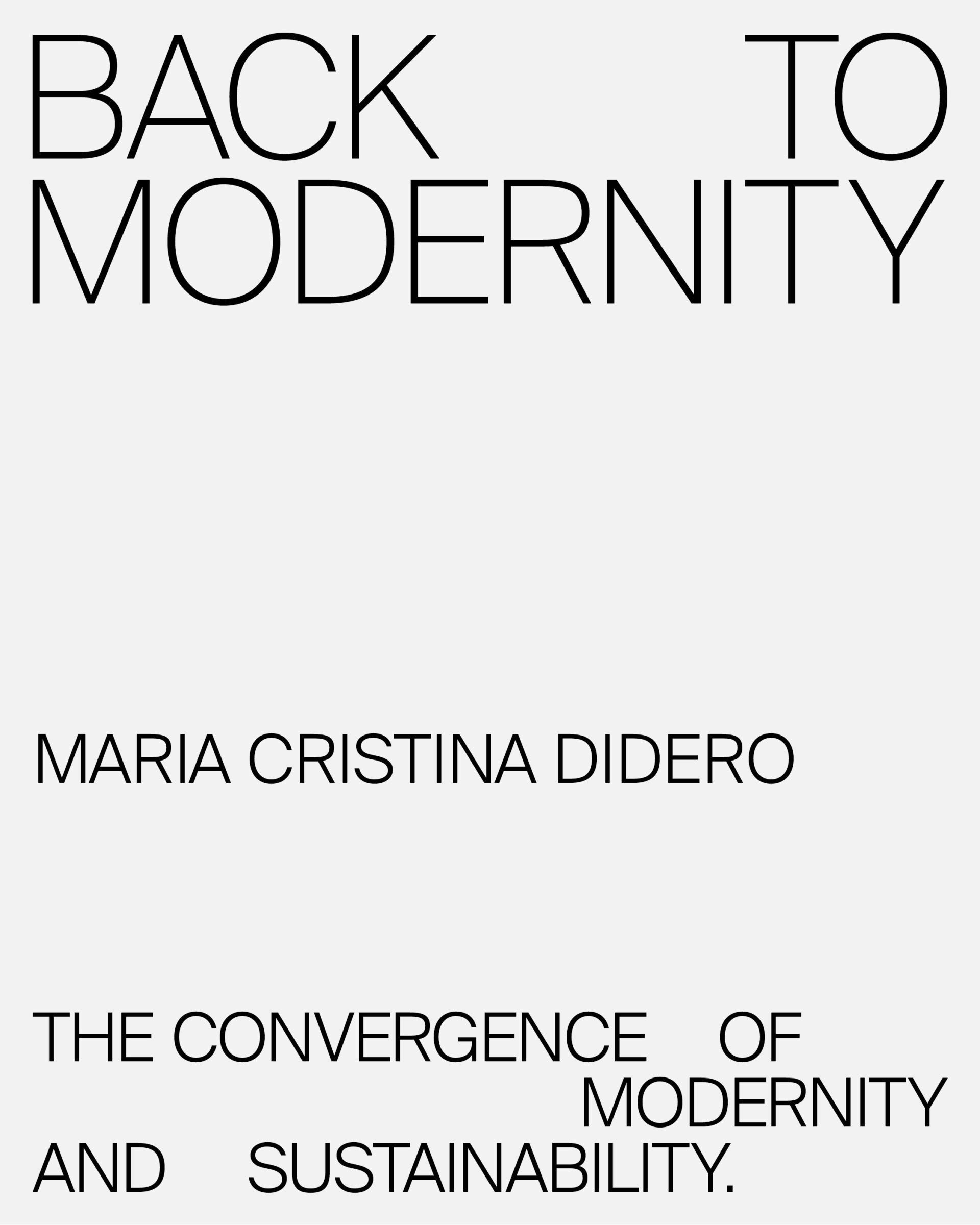
Se dovessi considerare la nozione di modernità secondo l’accezione più attuale, e più consona ad una chiave futura, direi che potrei affermare senza paura che modernità oggi è sinonimo di sostenibilità. Sostenibilità è sinonimo di condivisione. E condivisione significa lavorare all’unisono per un mondo migliore. Per tutti. Tema cruciale per i nostri tempi, decisivo nel determinare le azioni future, sostanza di proposte che dovranno forgiare la coscienza di produttori e consumatori degli anni che verranno, la sostenibilità sembra essere sulla bocca di tutti, ma forse gli interventi concreti sembrano essere limitati, si agisce in maniera ridotta.
Nemmeno il mondo del design può e deve sfuggire a queste istanze. Progetto, design, cultura delle persone: nessuno di questi aspetti può essere estraneo alla questione: si tratta di rideterminare una nozione ampia di significato che investe, nel complesso, forme e strutture della produzione, risultati estetici, richieste del mercato e pensiero consapevole nell’acquisto. Certo: la percezione comune del valore di un oggetto disegnato oggi è già molto cambiata da quella di un tempo (quando il bello e il decorato dettavano legge e le considerazioni concettuali si limitavano per lo più a valutazioni estetiche) ma la consapevolezza, coscienza, conoscenza che il nostro pianeta (e noi con lui) ha un serio problema, comporta che la valutazione sulla bontà di un prodotto sia radicalmente cambiata. Si affacciano sul mercato acquirenti più responsabili: a loro le aziende devono essere in grado di rispondere. Non è solo un problema etico che le aziende, chi prima, chi dopo, sono arrivate finalmente a porsi.
È che nel mondo del progetto oggi esiste una reale e attenta richiesta da parte del pubblico, di prodotti rispettosi di determinati canoni, capaci di attestarne la reale qualità e di legittimarne l’esistenza con caratteristiche premianti: stile, economicità, resistenza. Una nuova modernità sostenibile. E forse è il momento di dire che le aziende questo l’hanno capito. Hanno capito che un prodotto sano incide ormai in maniera sostanziale “anche” sul successo commerciale, sulle vendite, sulla reputazione, sulla capacità di attirare un pubblico attento.
Gli imprenditori più illuminati ed avanzati, in questo campo, hanno compreso prima e assimilato poi l’esigenza di un cambiamento radicale. Non solo nella produzione, ma in tutti i settori della filiera produttiva. Tutti i processi sono oggetto di una riflessione e di un cambiamento che non è di facciata: fanno, e devono fare parte, dello stesso dna dell’impresa. Ne sono il presente, spesso ne continuano il passato, certamente sono le radici di un solido futuro. D’altra parte, l’industria non solo si è spesso adeguata alle richieste che avanza il mercato; talora ha preceduto, con coscienza gusti e tendenze, spesso dettandole.
Nel campo del design, ci sono già numerosi progettisti, architetti, artisti e associazioni che lavorano in questo senso e che hanno perseguito una tale strada fin dall’inizio del loro percorso. Anzi: per alcuni di loro, questa è stata addirittura l’ispirazione indispensabile per caratterizzare il proprio lavoro. Progettare, del resto, è un verbo che declina naturalmente il futuro. E bisogna perciò farlo sempre più in maniera responsabile. Il progettista e l’azienda (madre e padre di un oggetto), responsabili di numerose scelte che definiscono la traiettoria di un prodotto, valutano la maniera per realizzarlo.
Dalla scelta delle materie all’economicità complessiva, fino al “pensiero attivo” che prevede un ciclo per il prodotto che va dalla sua nascita a quello della sua fine e adesso, possibilmente, al riutilizzo. Condividere e riutilizzare, riusare, ripensare: ecco quello che bisogna fare oggi. E poi agire, perché non c’è più tempo e forse non c’è più nemmeno scelta. “The house is on fire” sostiene Greta, e noi lo sappiamo. Maria Cristina Didero
BIOGRAFIA
Curatrice di design indipendente, autrice e consulente, Maria Cristina Didero ha collaborato con riviste tra cui Domus, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Flash Art, Apartamento ed è stata editor-at-large di ICON Design dal 2018 al 2020. Attualmente ricopre il ruolo di Milan editor per Wallpaper magazine. Maria Cristina ha contribuito a molte pubblicazioni e collaborato con molte aziende. Lavora a livello internazionale, curando mostre per istituzioni, fiere ed eventi dedicati al design. Ha lavorato per Vitra Design Museum per 14 anni. Nel 2021 è parte della squadra curatoriale scelta da Stefano Boeri, incaricata del public program per l’edizione del Salone del Mobile, Supersalone mentre nel 2022 è stata nominata direttore curatoriale della fiera Design Miami/ e ha presentato un progetto al MK&G di Amburgo dal titolo Ask Me If I Believe in the Future.
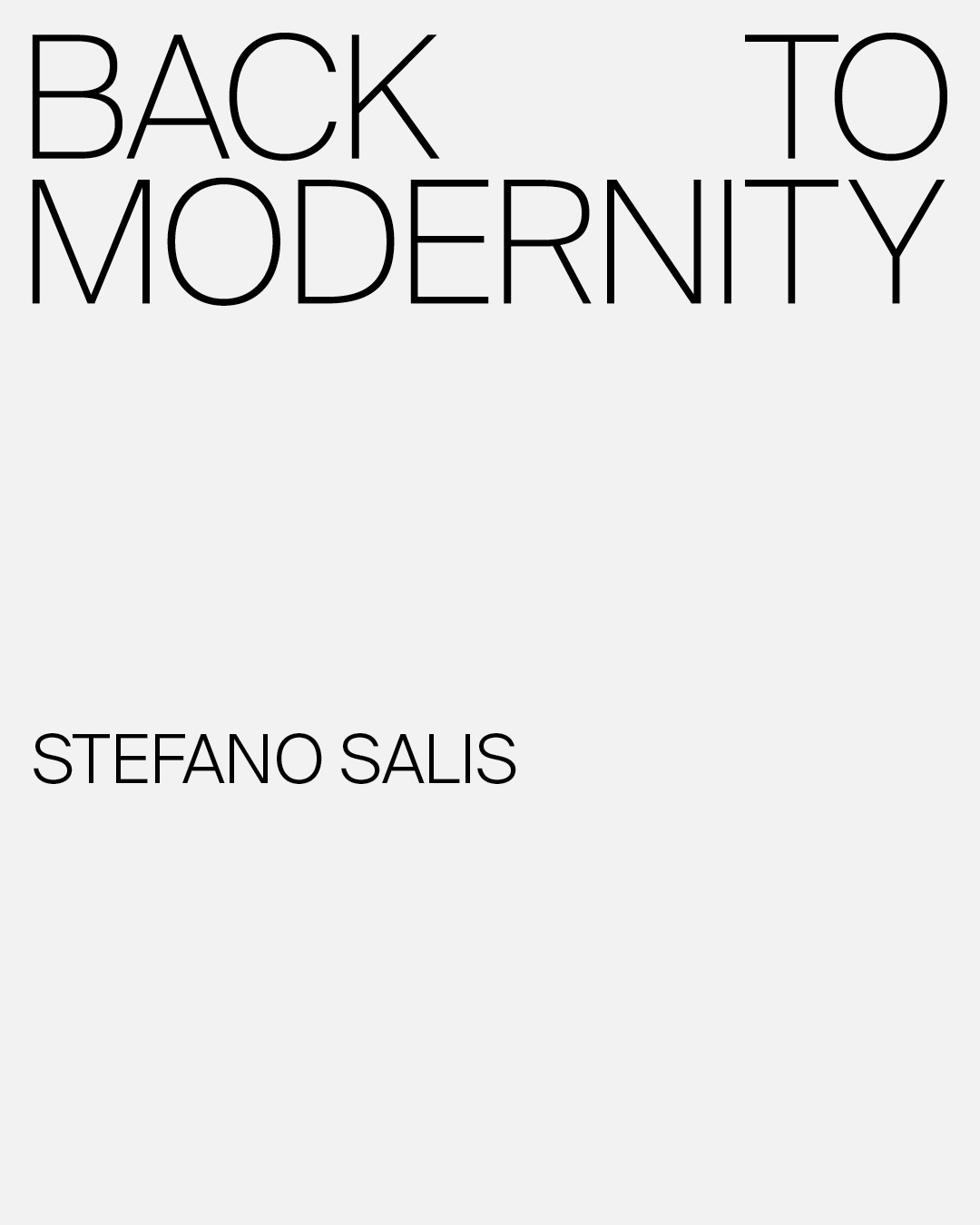
Modernità è una parola affascinante, anche solo a dirla, o a farsela girare tra le labbra nel pensiero. Seduce e appaga i sensi: dà sempre un senso, molto concreto, di benessere; ci ricorda che viviamo con slancio il nostro tempo ma, anche, che lo possiamo superare: da protagonisti. Moderno, infatti, si contrappone ad antico o a vecchio e porta con sé un’idea di “giovinezza” di idee, e risultati, che serve a guardare oltre l’orizzonte del già noto. Mantiene, costantemente, una sensazione positiva. Proprio per questo, però, è una parola da usare con cautela. Non è certamente una panacea, né sopporta la falsità: non si può far finta, insomma, di essere moderni o innovativi. O lo si è per davvero, o no.
Modernità non è una parola: è una attitudine, è una visione. Un progetto di largo respiro e di lungo percorso; un cambiamento, collettivo ed individuale, che si compie mentre lo si realizza. Non ci sono strade segnate, dunque, ma sperimentazioni da fare, vie da percorrere con la sensibilità (collettiva ed individuale) che muta, e con le esigenze diverse che i tempi richiedono alle persone di ingegno e alle fabbriche che si incaricano di tradurle in realtà. Modernità è cultura; strumento del conoscere e del vivere che interroga continuamente il nostro modo di essere.
La modernità si declina in un arcobaleno di idee cangianti, che puntano a smentire i profeti di sventura sempre pronti alla previsione di catastrofi ma evidenziano, anche, i sentieri che si sono rivelati sbagliati, li rendono perfettibili. Di più: così come è oggi, se portiamo il concetto dentro il mondo del design, se si può dire che non è più sostenibile produrre e progettare secondo vecchi canoni, materiali e idee – e facciamo solo l’esempio della bistrattata plastica – così, d’altra parte, non vanno demonizzate tecniche ed espressioni che, in molti casi (ed è stato proprio quello della plastica su scala industriale), hanno concesso ad ampi strati di popolazione di entrare finalmente nel benessere e nella comodità: un’eredità decisiva del Novecento. Storia del concetto di modernità (in Italia in particolare), una sua precisa declinazione nel mondo del design e uno sguardo sul futuro che ci attende: sono le tre linee guida che seguiranno in queste pagine. Esperti indubitabili della materia come Giuseppe Lupo, Deyan Sudjic e Maria Cristina Didero, ci raccontano, ognuno con la sua angolazione, in testi succinti ma precisi, cosa significa pensare a questi concetti, ci disegnano una mappa di significato che orienta la nostra consapevolezza.
Se parole come benessere, innovazione, sostenibilità, ma anche incomprensione, fraintendimento, svolta, cambiamento di rotta si insinuano in questi testi, esse sono la spia più evidente della criticità che pone il concetto; ed è il sale stesso della discussione. Per chi fabbrica, per chi compra, per chi usa, per chi vive il design (e non solo il design), gli oggetti del cambiamento sono i soggetti di una nuova possibilità di interpretare ruoli e destini, non sembri, questa, una parola troppo grande. Perché la modernizzazione non è fatta solo di scommesse sul futuro, ma anche di memorie e di passioni. Di rispetto per le cose ben fatte, con quella qualità e amore per il compiuto, che sono valori intramontabili. Di cura durevole dei dettagli. Della consapevolezza di circondarsi di oggetti che ci parlano della nostra identità: anzi, la rendono esplicita. Insomma, essere moderni, essere “dentro il tempo”, non è mai stata questione di avere i gadget tecnologici di ultima generazione, non è un vantarsi di poter godere di ritrovati scientifici che fino a qualche decennio fa erano impensabili, non è essere (fintamente) sociali perché queste sono le regole che ci impone la moda.
Moderno è avere un atteggiamento di comprensione ed empatia con ciò di cui ci circondiamo, con ciò che serve a farci stare dentro un contesto, il nostro. Nuovi modi di vivere, che certamente verranno, sono la grande opportunità che fronteggia chi oggi si confronta con la dimensione di una esperienza sociale e culturale che deve trovare soluzioni diverse a problemi nuovi, e soluzioni innovative a problemi che si ripresentano. Un grande filosofo come Zygmunt Bauman in “Modernità liquida” aveva scritto: “Ci si sente liberi nella misura in cui l’immaginazione non supera i desideri reali e nessuno dei due oltrepassa la capacità di agire”. Immaginazione, reale, capacità di agire, desiderio: dentro questa nuvola di parole ci muoviamo con la consapevolezza che i limiti di ieri sono le realtà di oggi, e le possibilità di domani sono la nostra voglia di progettare, instancabilmente, un nuovo vocabolario di parole, cose, e anche persone. I riti di una liturgia laica che parla al nostro spirito in maniere sorprendenti e affidabili. La modernità non è un traguardo, ma il prossimo pezzo di strada. Stefano Salis
BIOGRAFIA
Sardo di Sant’Antioco (1970) Stefano Salis è giornalista presso il Sole 24 Ore, dove ricopre l’incarico di responsabile della pagina dei Commenti. Si occupa regolarmente, sul supplemento domenicale, di bibliofilia, editoria, arte, design e letteratura. Ha tenuto conferenze su questi argomenti in tutto il mondo e corsi universitari di giornalismo presso l’Università di Milano e presso la Cattolica. Tra i suoi contributi in forma di libro ricordiamo la curatela (con Barnaba Fornasetti) di Piero Fornasetti. Certi paraventi sono stati disegnati due volte (Henry Beyle). Il suo ultimo libro è Sulla scacchiera (Franco Maria Ricci editore). Di prossima uscita un libro sulle pietre di Roger Caillois (Franco Maria Ricci). È nel comitato di direzione della rivista FMR.
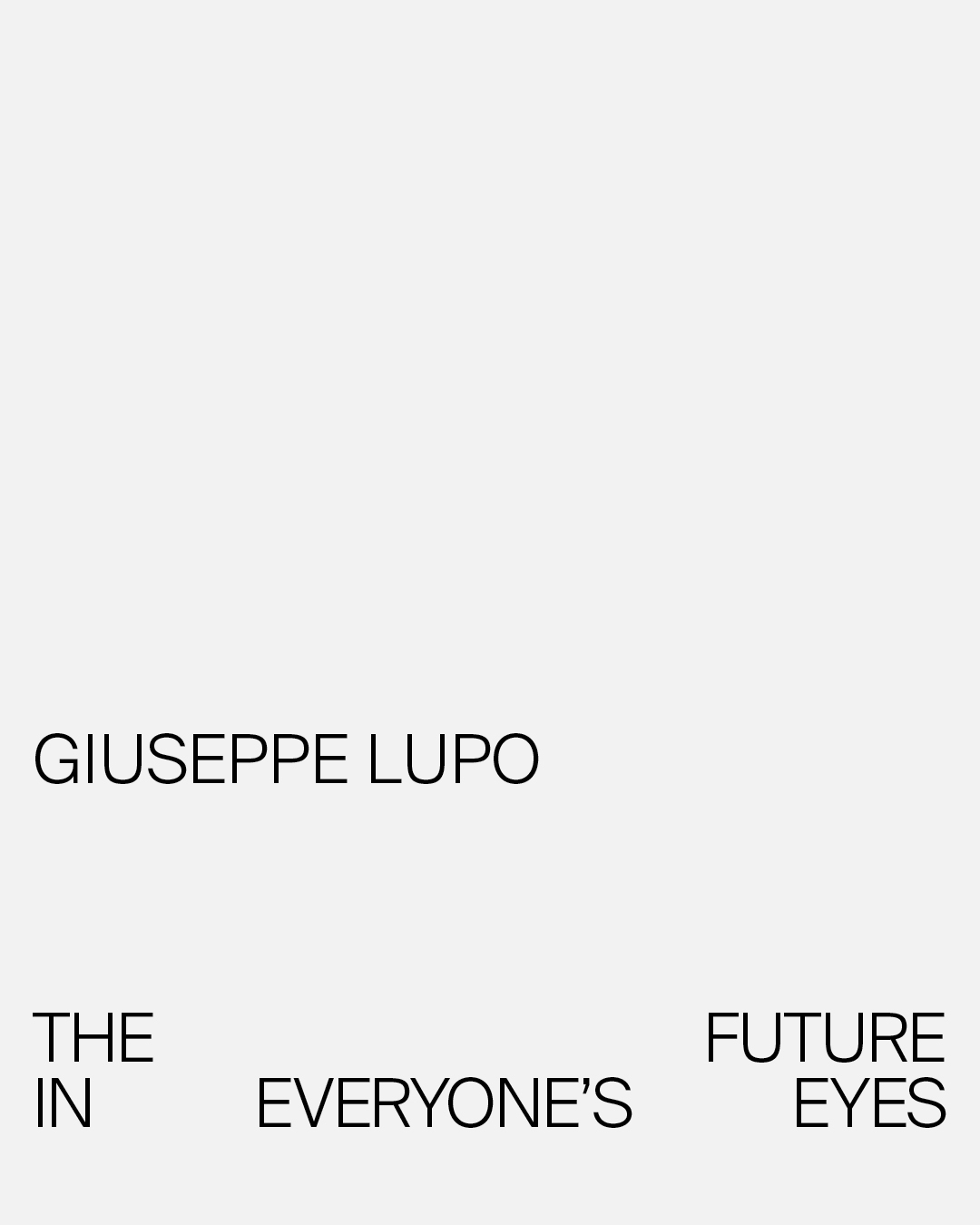
Quando si pronuncia il termine modernità, oggi come in passato, il pensiero corre subito alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nel secolo scorso, tra gli anni Quaranta e i Cinquanta, epoca in cui il passaggio dalla civiltà della terra alla civiltà delle macchine faceva acquisire al nostro Paese un volto industriale. Tale avvenimento, che ha una dimensione epocale, è un segno di discontinuità rispetto al passato, individua un punto di non ritorno, perché, prima ancora che sull’economia, i cambiamenti hanno inciso sui modelli di comportamento degli individui, sul tessuto antropologico delle famiglie e dei gruppi sociali, perfino sull’idea di paesaggio urbano e di periferia.
Nessuno, infatti, ripensa oggi al Novecento privo delle questioni ideologiche che sono sorte con l’irrompere della tecnologia. Noi non conosciamo la modernità, ma i suoi riverberi, ne misuriamo gli effetti che erano sotto gli occhi di tutti e si concretizzavano nel moltiplicarsi di oggetti prodotti nelle fabbriche – dai componenti per l’arredamento agli elettrodomestici, dalle automobili ai vestiti –, figli di un’antica sapienza artigiana, che le fabbriche hanno saputo incentivare e valorizzare grazie al design, creando così quello stile inconfondibile a cui è stato dato l’etichetta di Made in Italy. In poco meno di un quindicennio, l’Italia è stata in grado di rinnovare radicalmente l’immagine di sé nel mondo: da nazione povera e sconfitta, da patria di emigranti a culla del bel vivere, scuola di eleganza e raffinatezza. Un avvenimento di tale portata, se da un lato ha provocato il dilagare dei consumi e l’affermarsi di una società di massa (due fenomeni generalmente presi a bersaglio dagli uomini di cultura), dall’altro ha felicemente appagato la quotidianità di un popolo che fino al dopoguerra non conosceva il concetto di stabile benessere, anzi viveva una condizione di precarietà, per non dire di indigenza.
Dire Novecento, dunque, equivale a dire modernità industriale, con tutto ciò che questa formula ha significato nel campo della politica, della cultura, dei linguaggi filosofici ed economici. Il problema non è stato solo il rapido consolidarsi di un livello tecnologico, inevitabile e necessario per una nazione che intendeva collocarsi dentro lo scacchiere occidentale. È stata la reazione al cambiamento tanto nella gente comune quanto nelle élite intellettuali, il senso di disagio, la frattura profonda con il vecchio mondo e anche una certa diffidenza nei confronti del nuovo. Gli uomini di cultura si sono fatti carico di queste problematiche e ne hanno registrato le oscillazioni, motivo per cui, per esempio, la letteratura che si è occupata di questi argomenti può essere letta come termometro di un atteggiamento, il più delle volte corrosivo nei risultati e severo nei giudizi, espressione di un’antimodernità (più che di una convinta adesione alla modernità) che affondava le sue radici nel sostrato ideologico di un secolo complicato, votato allo scontro tra i modelli di società anziché al dialogo e all’integrazione. Proprio qui si nasconde una paradossale contraddizione.
Da una parte, il fronte degli intellettuali, che il più delle volte ha male interpretato i risultati dell’industrializzazione, dando di essi una lettura scettica o negativa, come se il diffondersi dei beni di consumo fosse un errore strategico o una forma di obbedienza alla logica del capitalismo. Dall’altro, la gente comune – famiglie di operai e impiegati, piccola e media borghesia – a cui invece la fabbrica, mettendo a disposizione i suoi oggetti, regalava la possibilità di accedere a un livello più elevato nella qualità della vita, di sentirsi partecipi di qualcosa assai più grande del singolo destino: una ventata di aria nuova, che attraversava il mondo e riempiva di futuro gli occhi di tutti. Giuseppe Lupo
BIOGRAFIA
Nato in Lucania, Giuseppe Lupo vive in Lombardia, dove insegna Teoria e storia della modernità letteraria presso l’Università Cattolica di Milano. Nel 2018 ha vinto il Premio Viareggio con Gli anni del nostro incanto e nel 2011 il Premio Selezione Campiello con L’ultima sposa di Palmira. È autore di numerosi altri romanzi, fra cui L’americano di Celenne, La carovana Zanardelli, Viaggiatori di nuvole, L’albero di stanze, Breve storia del mio silenzio e Tabacco Clan (2022). Ha pubblicato diversi saggi sulla cultura del Novecento e la modernità industriale. Il suo ultimo libro è La modernità malintesa (2023). Collabora alle pagine culturali del «Sole-24Ore»
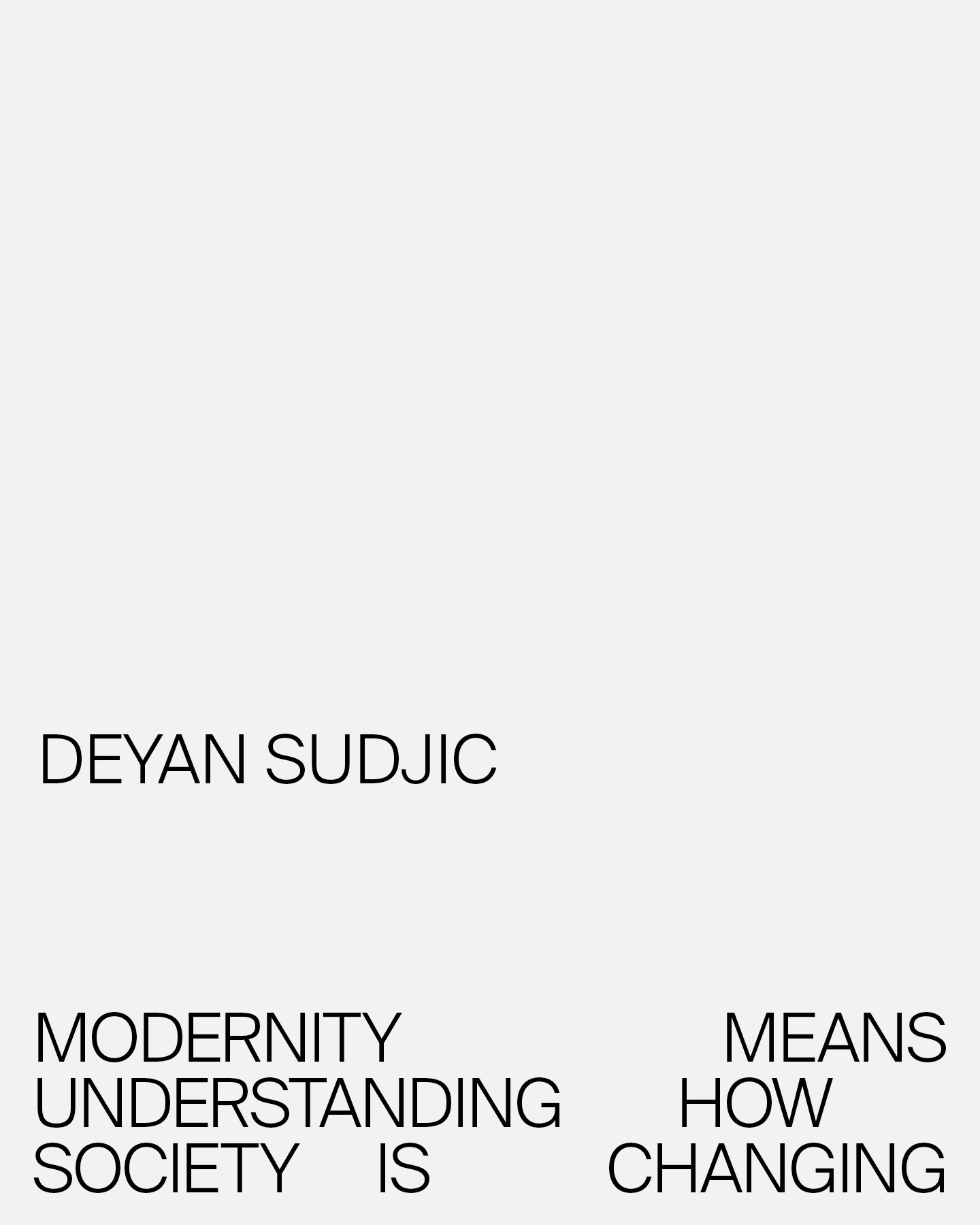
Andy Warhol, negli anni 60, spinse l’arte moderna dentro ai libri di storia per far posto all’alternativa meno ideologica dell’arte contemporanea. L’architettura moderna fu dichiarata morta dal critico postmodernista Charles Jencks nel 1972. Ma anche se i postmodernisti si sono divertiti a progettare alberghi per la Disney con la forma di un gigantesco cigno e a usare calcestruzzo prefabbricato per costruire palazzoni di case popolari che facevano la parodia del Colosseo nelle banlieues parigine, non siamo riusciti a rinunciare al concetto di modernità. Da un certo punto di vista, la crociata morale che il modernismo un tempo rappresentava è stata rimpiazzata da una nostalgia per la certezza che il «moderno» un tempo rappresentava. È una nostalgia che possiamo osservare nella fascinazione che l’architettura brutalista e l’arredamento modernista di metà Novecento esercitano su una generazione di hipster.
Ne possiamo vedere un riflesso nell’omaggio agli elettrodomestici Braun di Dieter Rams da parte di Jony Ive nel suo progetto per la Apple, e nell’importanza che continua ad avere il lavoro di pionieri del modernismo come Jean Prouve e George Nelson per l’industria del mobile. Non è difficile comprendere il fascino di un design che resiste al passare del tempo. C’era qualcosa di speciale nelle opere di Rams e in quelle di Charles e Ray Eames, qualcosa che le ha fatte durare. Guardate l’architettura della Eames House a Santa Monica, realizzata con componenti industriali standardizzati: sembra fresca e nuova come il giorno in cui è stata completata, nel 1949, a differenza dell’obsolescenza programmata degli elettrodomestici da cucina (ancora in loco) da usare per i quali non avevano altra scelta.
C’è un altro aspetto, meno sentimentale e forse più importante, nel fascino della modernità. L’esplosione dei social media e l’adozione universale dello smartphone, introdotto appena sedici anni fa da Steve Jobs, inizialmente erano state raffigurate descritte come nuove tappe nell’evoluzione della modernità e invece hanno avuto la conseguenza non voluta di contribuire a ricacciare il mondo verso una condizione premoderna.
Twitter doveva dare più potere all’individuo e invece minaccia di riportarci al Medioevo, con le sue intolleranze, testimoniate dal ritorno di superstizioni antiche contro i vaccini e i pregiudizi contro gli estranei, purtroppo ricomparsi in una nuova era di irrazionalità. Dobbiamo trovare modi nuovi per usare la tecnologia, per ripristinare alcune delle qualità e delle libertà che sono parte essenziale della modernità.
Essere moderni non significa scegliere uno stile invece di un altro. Significa trovare modi per mettere la tecnologia al servizio della gente. Significa capire come sta cambiando la società. Significa ricerca, prove concrete, ragione, comprensione. Terence Conran diceva che il design è l’intelligenza che diventa visibile. La tecnologia non rimane immobile.
La modernità un tempo erano le sedie a sbalzo in tubolare d’acciaio. Buckminster Fuller prendeva in giro, giustamente, i modernisti della scuola Bauhaus perché si preoccupavano solo di quello che potevano vedere nel loro mondo, perché disegnavano i rubinetti senza curarsi delle tubature e degli ingegneri che li rifornivano di acqua. Il critico inglese Reyner Banham, ancora negli anni 60, pronosticava un futuro in cui la mobilia sarebbe scomparsa del tutto. Per molti versi, siamo in un’epoca in cui gli oggetti si sono dematerializzati, come ipotizzava lui. Dobbiamo cercare nuovi modi di essere moderni, e modi moderni per trovare il conforto che abbiamo sempre ricercato nei nostri possedimenti fisici, quella capacità che hanno di riflettere la nostra vita e la nostra memoria.
Deyan Sudjic. English to Italian translation by Fabio Galimberti.
BIOGRAFIA
Deyan Sudjic è un critico e uno scrittore. Ha diretto la rivista Domus a Milano, è stato direttore della biennale di architettura di Venezia e ha curato mostre a Londra, Istanbul, Copenaghen e Seul, su argomenti che vanno da Stanley Kubrick a Zaha Hadid e Paul Smith. Il suo libro The Language of Things è stato pubblicato in dieci lingue, fra cui l’Italiano (Il linguaggio delle cose, Laterza 2009). È il direttore di Anima, una nuova rivista di design lanciata nell’aprile del 2023.